Natale Pia
La Storia di Natale
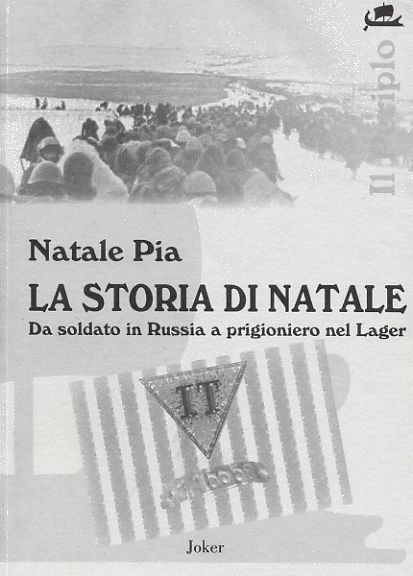 La storia di Natale è il racconto autobiografico commovente e coinvolgente di un astigiano che ha vissuto alcune delle situazioni più tragiche della II Guerra mondiale.
La storia di Natale è il racconto autobiografico commovente e coinvolgente di un astigiano che ha vissuto alcune delle situazioni più tragiche della II Guerra mondiale. Natale è giovanissimo soldato in Russia e si trova ad affrontare difficoltà impensate con il solo aiuto della forza di volontà, tra uomini alle prese con il freddo, la fame, la mancanza di equipaggiamento e di guida, ognuno abbandonato a sé stesso e al caso, all’eventualità di passare accanto alla tragedia di altri senza esserne travolto oppure di rimanerne vittima, in tutti e due i casi senza merito e senza colpa.
Il racconto si snoda con una precisione e pacatezza che fa sentire il lettore partecipe delle traversie della ritirata, culminate a Nikolajewka.
Tornato in Piemonte con la convinzione di essere stato fortunato ad uscire dalla tragedia russa, pur se indelebilmente segnato, dopo l’8 settembre collabora alla lotta partigiana nell’Astigiano.
Catturato dai tedeschi ripercorre il passo del Brennero destinazione Mauthausen in condizioni ben peggiori della prima volta ed è ridotto a un oggetto, un numero, un “pezzo da lavoro” nelle mani di spietati aguzzini, dove la volontà non conta nulla se non è la pura volontà di resistere, di non lasciarsi travolgere dall’inumanità che lo circonda.
Nel Lager non si è abbandonati a sé stessi, si è parte di un ingranaggio perfetto nella sua nefandezza, si assiste impotenti al trionfo dei peggiori comportamenti umani perché anche coloro che torturano i prigionieri sono uomini ma trattano i propri simili peggio degli animali, senza capire che le bestie sono loro, come dice Natale «senza offesa per le bestie».
Natale è un uomo normale, che si è trovato coinvolto in tragedie immani, e come succede a molti sopravvissuti come lui non si rassegna, non si stanca di raccontare e trasmettere ai giovani o a chi ha voglia di ascoltarlo un messaggio di pace, di dimostrare che l’odio produce solo distruzioni, nel corpo e nell’anima.
La sua è semplicemente la storia di una persona che pur tra difficoltà inaudite non ha perso mai il rispetto di sé e degli altri.
-------------------------------------------------------------------------------------
LA STORIA DI NATALE
Da soldato in russia a prigioniero nel lager
edizioni JOKER Novi Ligure
info: storiadinatale@yahoo.it
-------------------------------------------------------------------------------------
il volume ci è stato richiesto dalla Fondazione Gramsci di Torino per la sua biblioteca;
è presente nell’ Istituto di romanistica dell’università di Salisburgo che lavora da anni ad un Progetto Mauthausen ed una parte di esso è in una antologia curata dalla prof. Pflug;
sono a buon punto gli accordi per una sua presenza presso i book center di Mauthausen, Gusen e Ebensee;
è presente nella biblioteca dei Compagnons de la memoire di Bruxelles insieme a una cassetta con la testimonianza diretta di mio padre rilasciata l’estate scorsa;
è presente nella Biblioteca archivio “Aldo Revelli” presso l’A.N.E.D. di Milano;
è presente nella biblioteca dell' A.N.E.D. di Torino di cui è membro il papà
è presente nel Memoriale di Carpi e ben presto lo sarà anche in quello di Fondo Toce
la presentazione ad Asti è stata recensita ampiamente da La stampa nelle pagine locali
a maggio saremo alla Fiera del libro di Torino nello spazio Deportazione
per settembre è prevista la presentazione presso la Regione Piemonte
---------------------------------------------------------------------------------
Prefazione
Con discrezione, quasi a bassa voce, questo libro di memorie racconta la storia di una doppia sopravvivenza: alla tragedia della sciagurata campagna di Russia - che si consuma, per l’autore, dal maggio 1942 e il luglio 1943 - e alla prigionia nel Lager nazista di Mauthausen e più precisamente in uno dei suoi peggiori sottocampi, quello di Gusen.
In questa seconda parte (strettamente legata, come si vedrà, dal punto di vista sia fattuale che narrativo alla prima) la testimonianza di Natalino Pia si aggiunge a un già esistente e variegato mosaico di voci che hanno raccontato le vicende degli oltre cinquecento “politici” mandati a morire a Mauthausen con il suo stesso “trasporto”, penultimo dei grandi convogli (composti da almeno 500 deportati) partiti dall’Italia per tale destinazione. Alcune sono voci note, che costituiscono rilevanti punti di riferimento nella “letteratura di Lager”: quelle di Piero Caleffi, con Si fa presto a dire fame (1954), e di Vincenzo Pappalettera, con Tu passerai per il camino (1965)1. Due testimonianze che hanno fondato e connotato la memoria della deportazione “politica” (ma non solo) italiana, e anche contribuito a impostare linee di ricerca storiografica (com’è il caso delle ricerche di Pappalettera sui nominativi dei deportati). Da quegli anni ormai lontani, storia e memoria della deportazione si sono intrecciate e vicendevolmente arricchite, in uno scambio reciproco che ha influenzato e influenza le voci di chi - come Natalino Pia, che ha steso questi ricordi molto di recente - racconta oggi avvenimenti di cui, nonostante la grande distanza di tempo intercorso, possiede inevitabilmente una percezione più ampia, perché li può inquadrare in un contesto più generale e più noto, e confrontarli con altre forme di memoria.
È dunque, questo, un libro che appartiene alla fase più recente della “letteratura di deportazione”: lo rivela il segno caratteristico dell’ampliamento della memoria autobiografica, che si estende oltre il momento chiave della deportazione, nelle due dimensioni del “prima” e del “dopo”, molto significative per il lettore d’oggi. Così il racconto comincia con le vicende familiari e iscrive le vicende della Russia e di Mauthausen in una cornice apparentemente più ampia del necessario. Meno visibile, ma comunque presente o per lo meno avvertibile nella narrazione, l’altro segno di questa “memoria lontana”2: il collegamento tra l’esperienza personale, gli avvenimenti storici e il confronto, anche minimo o poco esplicitato, con altre esperienze.
Ma pur con queste caratteristiche comuni ad altre memorie, il racconto di Natalino Pia procede con una sua cifra particolare. In parte ciò è dovuto all’eccezionalità della propria vicenda, che è quella già detta all’inizio di una doppia sopravvivenza. La guerra compare a volte nel racconto e nella memoria dei deportati, e più frequentemente, è ovvio, in quella frazione di internati militari finiti, con percorso anomalo, in Lager (KZ) anziché nei campi di concentramento e detenzione per IMI. Ma non credo che esistano molti racconti in cui il KZ è preceduto dal Don e da Nikolajevka. E tuttavia, Natalino Pia non affianca le due vicende - la ritirata di Russia e Mauthausen-Gusen - per stupire il lettore, o per esibire l’eccezionalità della sua esperienza (di cui è, in ambito privato, e giustamente, ben consapevole). Il doppio racconto è invece necessitato da una memoria che vuole sia fissare le linee fondamentali del proprio vissuto, sia ricercare in questo vissuto un senso e una spiegazione. Per questa volontà di rielaborazione, insomma, saremmo più vicini a quella che Fortini chiama autobiografia in senso proprio, e un po’ più lontani dalla semplice memoria degli avvenimenti, comunque presente nell’intenzione e nella realizzazione, ma subordinata alla prima.
Si è però detto che la caratteristica del racconto (del libro) è quella di una “voce bassa”, di un sottotono, di una “misura onesta”3 che tende, più che alle grandi interpretazioni, alla discrezione della dimensione personale e privata; quasi che alla narrazione il protagonista si avvii controvoglia, non solo per la difficoltà di trovare il linguaggio adeguato agli avvenimenti, ma per quel ritegno a pubblicizzare le proprie vicende che è testimoniato, sempre in questo volume, dalla figlia Primarosa, promotrice prima ancora che curatrice del libro. Un ritegno che tradisce un antico dolore, una ferita non cicatrizzata, quella della propria sopravvivenza a fronte dei compagni “che non ce l’hanno fatta”: è la doppia ferita dichiarata alla fine del racconto, in una pagina semplice e drammatica proprio nella sua schiettezza.
Che questa memoria, del resto (e questa è una cifra della letteratura di deportazione), sia una memoria sofferente e ferita appartiene pienamente alla consapevolezza dell’autore: lo dichiara nel pur lapidario e scarno “patto autobiografico” d’inizio, che nella sua spontaneità (quattro righe ridotte all’essenziale e immediate) viene poi riconfermato dalla parte conclusiva, anche qui senza artificio. È la memoria delle vite spezzate che impedisce al superstite una vita pienamente serena: “quel periodo ... mi torna ancora alla mente troppo spesso per consentirmi di vivere pienamente sereno”, “ancora oggi, benché siano trascorsi più di cinquant’anni, non passa giorno che il mio pensiero non torni alle troppe persone che non ce l’hanno fatta, e hanno perso la loro vita”.
Non si tratta di espressioni, in qualche modo, di circostanza, o figurate. La dinamica della scrittura di queste memorie lo mostra: come osserva Primarosa, la prima e unica stesura manoscritta procede “senza aggiunte, cancellature o ripensamenti”, e così è effettivamente per chi raffronti il testo, pur con i lievi rimaneggiamenti necessitati dall’edizione a stampa, con le pagine originarie. La scrittura è continua e sicura, chiara e assolutamente priva di esitazioni, come se chi scrive abbia da molto tempo impresso nella mente una versione definitiva, passata poi parola per parola sulla carta. La stessa nota di Primarosa ci informa che l’intenzione era quella di una scrittura in qualche modo “privata”, anche se poi è subentrata la prospettiva di trasmetterla alle altre generazioni.
Si possono rintracciare, per questo passaggio, alcune sollecitazioni esterne, più e meno vicine: certamente, tra le prime è stata l’intervista, curata da Cesare Manganelli, per l’Archivio della Deportazione Piemontese (settembre 1983), poi confluita nel coro di voci della Vita offesa4 . Un esempio più diretto è quello, una decina d’anni dopo, dell’amico - e a suo tempo compagno di deportazione - Felice Malgaroli con il suo libro autobiografico5. Infine, in seguito a un viaggio nell’aprile 1998 con studenti e insegnanti delle scuole superiori della Città di Moncalieri, l’esperienza della testimonianza resa sui luoghi, raccolta e riversata in scrittura da quei ragazzi a cui la testimonianza era rivolta6: una specie di nucleo, molto condensato, del presente libro, o perlomeno della seconda parte di esso.
Ma certamente tutto questo non avrebbe agito senza un lungo e ininterrotto dialogo non solo con i propri ricordi, ma anche con i luoghi. Insieme ai compagni dell’ANED (l’Associazione italiana dei deportati politici e razziali) e anche, spesso, per conto proprio e coi suoi familiari, Pia è tornato a Mauthausen e Gusen fin dagli anni ‘50; ha assistito alla trasformazione di Gusen, ha collocato e cura con attenzione, a ogni ritorno, la piccola lapide in memoria di Vittorio Benzi posta fra le tante del monumento italiano. In occasione del secondo viaggio moncalierese (marzo 2003), quando questo libro era già nella fase finale di elaborazione, si poteva notare come la testimonianza a voce fosse vicinissima, quasi identica, alla stesura scritta: certo per quella contiguità tra il ricordo ormai fermamente rielaborato e fissato in modo definitivo e chiaro.
Quali sono i contenuti di questa memoria, lo dichiara ovviamente il libro, e non c’è bisogno di riprenderli qui se non nelle linee essenziali, e per sottolineare alcuni punti. Dopo aver tratteggiato la storia della propria infanzia e prima giovinezza, inquadrandola in quella della famiglia di cui delinea rapidamente lo stato sociale e la vicenda (privata ma determinante per certi aspetti, come vedremo tra poco) dell’improvvisa morte della madre, si arriva al primo lungo racconto della campagna di Russia. Come promesso, il racconto è oggettivo e distaccato, il giudizio - ad esempio sulle ragioni di quella guerra, che fu di aggressione e a fianco dei nazisti - rimane sospeso, o meglio lasciato al lettore di oggi (uniche eccezioni, forse, il rapido accenno alla condizione degli ebrei lavoratori coatti nelle città tedesche e l’osservazione sul comportamento “arrogante e violento” dei soldati tedeschi). Ma la narrazione è ugualmente coinvolgente e drammatica, sia per quanto si può leggere tra le righe (un esempio per tutti, il rapido accenno all’equipaggiamento d’ordinanza, del tutto inadeguato perché in sostanza estivo, con cui Pia e i suoi commilitoni, abbandonati i camion, iniziano la tragica marcia che si concluderà positivamente, ma solo per pochi, a Nikolajevka) sia per il rapido crescendo con cui gli avvenimenti si susseguono, sempre più drammatici: l’apice dei quali potrebbe essere il racconto della lunga marcia di Pia nel dormiveglia e nel sonno, attaccato alle briglie del cavallo in groppa al quale ha preso posto l’apparentemente più fortunato sergente.
Vi è un “dopo” anche al termine di questa prima storia di sopravvivenza: ed è contrassegnato dalla impossibilità di dimenticare così come di far capire agli altri, espressa nell’episodio del ballo (situazioni analoghe si ritrovano frequentemente nei racconti di deportazione). Ma gli eventi incalzano, arrivano il 25 luglio e l’8 settembre. Questa zona del racconto, seppur rapidamente schizzata, è molto interessante anche perché offre e conferma un’immagine complessa e articolata della Resistenza, che non era fatta solo di partecipazione diretta, ma anche di appoggi e di contributi dati nell’ombra, ma a volte decisivi. Pia non è, propriamente, un partigiano arruolato, ma non ha esitazione a scegliere e a schierarsi, rischiando, e poi pagando, di persona, e pesantemente. Dapprima contribuisce alla formazione del gruppo partigiano di Davide Lajolo (“Ulisse”, confluito nelle brigate Garibaldi), poi è coinvolto (sempre nel suo Astigiano) nei rastrellamenti della prima settimana del dicembre 1944: organizza un nascondiglio che condivide con altri amici e partigiani, ma il rifugio è scoperto. L’imprevidenza di uno dei dieci, che ha dimenticato nello zaino il tesserino partigiano, provoca una violenta reazione dei nazifascisti. Pia potrebbe, se non salvarsi, almeno evitare di essere selvaggiamente picchiato rivelandone l’identità, ma un simile comportamento gli è estraneo (questo rapido riassunto non rende ragione della delicatezza e della sobrietà di tono con cui racconta gli avvenimenti): lo sbocco finale della vicenda è la deportazione al campo di transito di Bolzano e di lì al Lager di Mauthausen.
Di Bolzano viene data un’immagine tanto rapida (del resto i prigionieri del gruppo di Pia vi rimasero solo tre settimane, nel blocco dei “pericolosi”) quanto precisa: campo di transito sì, ma i prigionieri - come ammonisce la vista che si presenta al gruppo di prigionieri partiti da Torino, e alla quale si rimanda il lettore - sono sottoposti alle stesse procedure dei Lager (e del resto Bolzano era un Lager), a cominciare dagli appelli, dalle violenze e dalle botte. Ed è a Bolzano che Pia scopre sia la tremenda solitudine del prigioniero, sia il valore della solidarietà, che riguarda però solo piccoli gruppi di prigionieri, cementati da qualche vincolo comune (in questo caso la provenienza territoriale). È poi la volta del “trasporto”: almeno 501 persone, rinchiuse nei vagoni piombati in una fredda mattina del gennaio 1945, che arriveranno a Mauthausen dopo alcuni giorni di viaggio, contrassegnati da angoscia, freddo, fame, sete e qualche inutile tentativo di fuga7.
La storia che segue è quella di una calata in due gironi infernali: il primo è il campo principale di Mauthausen8, per pochi ma decisivi giorni - quelli della “quarantena”, ossia dell’iniziazione all’“ordine del terrore”9, alla sua forsennata violenza, alla fame, agli appelli interminabili e al gelo; in un rapidissimo flash-forward, Pia ci proietta le conseguenze di tutto questo: “Alla liberazione, dopo quattro mesi…avevo perso quaranta chilogrammi di peso”. Il secondo girone: il sottocampo di Gusen, a pochi chilometri da Mauthausen, che, per durezza e disumanità delle condizioni di prigionia e lavoro costituì una realtà a sé stante10.
Anche qui, è bene lasciare la parola a Natalino Pia, che con il suo racconto sequenzialmente ordinato, anche se a grandi linee, rende l’idea della disumana e implacabile progressione dello “sterminio attraverso il lavoro” che si consumò a Gusen. È importante capire che gli ultimi mesi del Lager furono, per molti aspetti, tra i peggiori (Gusen era sorto nel 1940); e che i prigionieri italiani al loro arrivo venivano ancora a trovarsi, nel 1945, in una posizione particolarmente difficile, che l’autore stesso sottolinea (“nella stube eravamo gli unici italiani, e i nostri compagni di camera erano tutti uniti nell’odio verso il nostro popolo, che era riuscito a essere il nemico di tutti”.
La ricerca della sopravvivenza percorre così anche strade individuali, nell’alternanza di imprevedibili casualità (il ritrovamento della bussola, oggetto perfettamente inutile, in quelle condizioni, ma che può anche costituire una potenziale risorsa nel paradossale mercato di scambi fiorito nel Lager) e di sottomissione alle crudeli leggi di un “mondo alla rovescia” (l’ingannevole promessa di una sistemazione migliore, o la punizione somministrata da un kapo spietato). Eppure, nonostante tutto, il narratore riesce a mantenere un tono dimesso e mai enfatico, senza abbandonarlo neanche nei momenti più difficili. Così lascia al lettore la visualizzazione della fame dei deportati, quando racconta, senza commento, che mangiano la colla destinata alle mole a smeriglio. E ben poche parole riassumono lo strazio dell’assurda punizione a bastonate, che lo conduce sull’orlo della fine: “furono solo giorni di pura sofferenza”. Ma la sopravvivenza presenta anche aspetti enigmatici. Natalino Pia propone, per i momenti più risolutivi della sua storia - e qui ci riferiamo all’insieme della narrazione, Russia e Lager - anche una lettura in certo modo provvidenzialistica, che dà un senso anche alla prima parte, e più privata, del racconto, quella delle vicende strettamente familiari. Nei momenti più difficili, o negli episodi risolutivi, egli avverte la presenza e l’aiuto della madre: un leitmotiv che percorre tutto il libro, presentato anch’esso con grande discrezione (“ringraziai... la mamma, che secondo me aveva cercato un modo per aiutarmi”), e che certamente si può leggere in chiave religiosa o soprannaturale, ma che anche si può interpretare come segno profondo di un legame tenace di umanità, un saldo filo con la propria storia e con il proprio io, che può aiutare a mantenere identità e sentimenti in un mondo totalmente disumanizzato.
Un’ultima vicenda tutta a sé è poi quella legata al ritorno, che descrive una realtà variegata e non scontata, in cui si affiancano la gentilezza di tre contadine austriache, l’infida vicinanza di ex prigionieri italiani, ma anche la sicura solidarietà del siciliano “Giorgio”. E infine, al concludersi dell’anabasi, la felicità del ritorno si accompagna alla scoperta che la ferita di quel passato non può rimarginarsi.
O forse, lo può, sia pure relativamente, proprio con il farsi racconto agli altri della propria storia. Natalino Pia ha voluto lasciare il suo bracciale di prigioniero, con il numero di matricola 115658, a una delle scuole di Moncalieri con i cui studenti ha rivisitato - tra le molte volte in cui è tornato in quei luoghi - Mauthausen e i suoi sottocampi. Come quel gesto, anche questo libro vuole essere un segno perché non si dimentichi quello che è successo, anche se ormai sessant’anni ci separano dalle guerre nazifasciste e dai campi di annientamento: eventi accaduti, ma che - per parafrasare Primo Levi e Mario Luzi (Il libro d’Ipazia) - immessi nella “eventualità continua del mondo”, non si esauriscono con il loro essere avvenuti.
Lucio Monaco
--------------------------------------------------------------------------------------
...dal testo...Destinazione Gusen I
La mattina successiva a quella tragica notte, fu organizzato un trasferimento verso un Campo di lavoro satellite del grande Campo di concentramento in cui mi trovavo. Anch’io feci parte del gruppo di circa centocinquanta prigionieri da trasferire.
Mentre ero inquadrato con gli altri in attesa della partenza, arrivò un nuovo trasporto dall’Italia del quale faceva parte anche un ragazzo del mio paese; riuscii a parlargli qualche minuto, ansioso di avere notizie della mia famiglia, ma restai deluso perché Giovanni Boggero era stato rastrellato nelle Langhe, colline della provincia di Cuneo, e non aveva notizie recenti provenienti dal nostro paese. Dovetti troppo presto andarmene lasciando lì l’amico appena incontrato; in seguito seppi che fu trasferito a Gusen II dove purtroppo la sua sorte fu simile a quella della maggior parte dei compagni.
La distanza che divideva i due Campi era di circa sette chilometri e il trasferimento si effettuò a piedi, con la scorta di molte guardie e di alcuni cani lupo. Come ho già detto, quello di Gusen era uno dei quarantanove campi satelliti in cui venivano smistati i prigionieri che giungevano a Mauthausen e valutati idonei a diventare lavorativamente produttivi; gli altri venivano soppressi al più presto perché considerati un peso per le riserve di cibo e di spazio. Come il Campo principale, anche questo prendeva il nome dal paese dove sorgeva, ed era formato da due campi distinti: Gusen I e Gusen II, separati l’uno dall’altro dal forno crematorio, dal Revier, infermeria, e dai magazzini. A Gusen I si lavorava per la fabbrica di armi Steyr, mentre al II si costruivano le carlinghe per la fabbrica di aerei Messerschmitt. In tutto eravamo circa ventimila persone costrette a lavorare in quei luoghi, sottoposti ai trattamenti disumani che sto per raccontare, limitandomi alla mia esperienza diretta.
Io fui destinato a Gusen I che sorgeva nei pressi di una collinetta ed era formato dalle solite baracche di legno, disposte in modo da lasciare tra l’una e l’altra delle stradine; ogni baracca era contrassegnata da un numero progressivo: a me e a tre altri astigiani fu assegnata la baracca 5, Stube B; lì mi trovai con un ragazzo di Mombercelli e due di Vinchio, paesi di cui ho già parlato, uno contiguo all’altro. Essendo i nostri cognomi tre con l’iniziale P e uno con la Q, ci avevano assegnato i numeri di immatricolazione successivi e qui eravamo stati divisi in blocchi secondo tale numero: per questo eravamo finiti insieme, non certo perché avevamo potuto sceglierlo. Come era capitato in Russia di trovarmi con amici nati a Vigliano e a Isola d’Asti, paesi posti in linea col mio se si va verso ovest, qui mi trovai con amici nati in paesi consecutivi al mio se si va verso sud-est.
Questo fu l’unico lato positivo della sistemazione, perché nella Stube eravamo gli unici italiani, e i nostri compagni di camera erano tutti coalizzati nell’odio verso noi e il nostro popolo, che in quella guerra era riuscito a essere il nemico di tutti, visto che avevamo combattuto contro tutte le nazioni d’Europa da cui provenivano gli altri deportati: c’erano infatti francesi, polacchi, russi, albanesi, greci, e anche tedeschi. Sicuramente nessuno di loro faceva sforzi per limitare il nostro isolamento causato dai grandi problemi di incomunicabilità dovuti soprattutto alla differenza di lingua.
L’interno delle baracche era uguale a quello già conosciuto, con la stessa suddivisione e lo stesso sovraffollamento nella camera riservata a noi prigionieri; l’unica differenza consisteva nella presenza di castelli di legno a due piani dove, in posti da 80 cm. per 180, dovevamo dormire in tre, due per un verso e uno per l’altro nel mezzo. Lo spazio era leggermente maggiore, ma i bordi di legno si conficcavano nelle carni, o meglio nelle ossa, visto che di carne ormai ne era rimasta poca.
Non avendo il problema della sistemazione dei bagagli, visto che non possedevamo nemmeno un pezzo di carta, dovevamo solo cercare un posto dove sistemarci per dormire ma, considerata la quantità degli occupanti, l’impresa si presentò ardua: io trovai posto in una cuccia già occupata da un russo e da un polacco in quel momento assenti perché al lavoro; al loro rientro, alle sei, non mi fecero certo una buona accoglienza ma anch’essi non erano in condizione di protestare.
Benché si dovesse lavorare duramente dodici ore al giorno e si vivesse costantemente immersi in quel freddissimo inverno austriaco il cibo, pur non differendo di molto, era anche peggiore di quello distribuito a Mauthausen; ancora più problematica era anche la cerimonia della distribuzione di quel cibo e la suddivisione del filone di pane: inquadrati tutti fuori dal blocco, veniva fatto entrare il numero esatto di persone tra cui doveva essere suddiviso il filone, raramente dieci, più spesso tredici, a volte quindici o anche più. Ormai eravamo diventati esperti in quella operazione, anche se effettuarla tra stranieri di almeno quattro nazionalità diverse comportava ulteriori problemi di comunicazione; peraltro eravamo costretti a risolvere la babele che ne veniva fuori nel minor tempo possibile, con il costante timore di attirare su di noi l’attenzione di qualche kapo che avrebbe comportato sicuramente l’attivazione dell’instancabile Gummi. Correndo il rischio di ricevere pesanti punizioni, visto che per i vantaggi che portavano ne valeva la pena, quasi tutti i prigionieri più anziani possedevano un coltello rudimentale ottenuto sagomando e affilando qualche pezzo di ferro trovato sul lavoro, e anche una bilancina formata da un’astina di latta lunga circa venti centimetri con tre pezzi di filo di ferro appuntiti, uno in mezzo e due ai lati: tenendo sollevata l’astina sospesa al filo centrale e infilando le fettine di pane nei due fili laterali quando tutto rimaneva in equilibrio le due razioni erano uguali.
Tutto questo impegno non rendeva la razione di cibo più abbondante o più gradevole, ma dava almeno l’impressione che la suddivisione fosse equa, e forse era anche un modo per maneggiare per più tempo un po’ di cibo che, se avessimo seguito l’impulso della nostra fame infinita sarebbe sparito in un batter d’occhio, come effettivamente avveniva quasi sempre appena ne entravamo in possesso, anche perché non esisteva modo di conservarlo salvaguardandolo dagli stomaci altrui. Con la stessa velocità sparivano il Würstel, non più grande di un sigaro, e la solita ciotola di brodaglia tiepida.
Al momento di coricarci l’estrema magrezza era nello stesso tempo un aiuto, perché ci consentiva di occupare meno spazio, ma anche fonte di disagio perché le ossa venendo a contatto direttamente le une con le altre senza l’interposizione dei muscoli causavano abrasioni alla pelle e gravi dolori articolari; sempre privi di qualsiasi indumento per ripararci, il contatto con i vicini era così stretto che i pidocchi avevano la possibilità di proliferare, formando nuovi incroci tra i nostri appena arrivati e quelli già abituati al luogo, molto più numerosi e pronti a occupare nuovi territori su di noi. Io dovetti così prendere posto tra il russo e il polacco, naturalmente in mezzo cioè tra due mucchi di ossa ostili, nel verso contrario ad essi, con i loro quattro piedi sul viso, e guai a muovermi o arrecare disturbo.
Dopo la solita sveglia alle cinque, orario in cui d’inverno era ancora buio pesto, si doveva correre al Waschraum, un ambiente semiaperto dove la temperatura era molto bassa, per lavarsi e per le altre necessità, il tutto anche lì senza poter utilizzare il più piccolo pezzo di stoffa o di carta, perché chiunque fosse stato trovato in possesso di queste cose sarebbe stato considerato sabotatore e punito molto pesantemente. Devo anche sottolineare come fosse assolutamente indispensabile evitare di bagnare gli indumenti che indossavamo perché molto difficilmente sarebbero asciugati ma quasi sicuramente la parte umida si sarebbe congelata, facendoli diventare duri e ancora più scomodi.
Sorbita velocissimamente la solita acqua sporca che loro definivano caffè, i tre occupanti della cuccia dovevano provvedere a riordinarla, ripiegando perfettamente il pagliericcio in capo al giaciglio e sovrapponendovi la coperta piegata e poggiata in modo millimetricamente simile a quella dei vicini, in modo che da capo della fila dei castelli si vedesse un’unica linea retta, senza la più piccola imperfezione; coloro che non eseguivano correttamente tale mansione la sera, al rientro dal lavoro, venivano puniti con un sacco di botte o magari anche con il salto del pasto.
Riuniti in gruppi da un kapo che poi era anche il caposquadra sul luogo di lavoro, alle sei meno un quarto, cioè a nemmeno un’ora dalla sveglia, dovevamo trovarci tutti sull’attenti sul piazzale principale per la solita tortura dell’appello: venivamo contati in file di dieci per dieci, a venti gradi sotto zero, coperti dai soli indumenti che sapete e non ultimo, considerato il nutrimento che avevamo addosso, la sofferenza era sempre più difficile da sopportare man mano che diminuivano le forze e le riserve di energia e solo chi ha provato può capire veramente. Essendo migliaia le persone da contare, pur pressate e picchiate, con un mucchio di «Mizzen ap» e «Mizzen alf», così mi ricordo io quell’ordine, la cosa non finiva mai troppo presto.
Sulla collinetta che confinava con l’area delle baracche-dormitorio, alta una quarantina di metri, su un enorme piazzale si trovavano le baracche-officina; sul confine c’era un’altra collinetta, questa rocciosa, all’interno della quale i deportati che ci avevano preceduti erano stati costretti a scavare parecchie enormi gallerie che venivano ancora ampliate continuamente, all’interno delle quali erano state installate altre officine.
A margine del piazzale del Campo base partivano due enormi scaloni divisi da una rete metallica che terminavano sul piazzale delle officine; al cambio di turno di lavoro gruppi di dieci file di dieci prigionieri formati dalle stesse persone che erano state inquadrate dall’appello salivano, e contemporaneamente altrettanti ordinati allo stesso modo scendevano; se nel gruppo che doveva scendere qualcuno era troppo debole o addirittura morto durante le ore di lavoro, o perché ucciso o a causa del troppo sfinimento, doveva essere comunque portato giù dai compagni che erano costretti a sorreggerlo o trascinarlo tenendolo sottobraccio. Tutto ciò era finalizzato a facilitare il conteggio dei prigionieri: tanti ne salivano tanti ne dovevano scendere a fine turno e se qualche presenza non quadrava erano veri guai.
Giunti sul luogo di lavoro ognuno doveva affrettarsi a raggiungere il posto che gli era stato assegnato, senza esitazioni, sempre rigorosamente in silenzio e con lo sguardo rivolto verso terra. Noi, che a confronto degli altri eravamo considerati “forze fresche”, è pacifico che fossimo assegnati ai lavori più faticosi e disagevoli, quelli all’esterno, i più esposti al freddo e alle intemperie, cioè al rifornimento alle officine del materiale che serviva alle lavorazioni, al prelievo del prodotto lavorato e del materiale di scarto. Movimentavamo cemento, pietrame, macchinari, ma soprattutto grandi cassoni di pezzi di Maschinepistolen, in entrata per la lavorazione e in uscita come materiale finito, l’assemblaggio avveniva altrove.
------------------------------------------
del libro LA STORIA DI NATALE
si parla nel volume di
Dario Venegoni:
UOMINI, DONNE E BAMBINI NEL LAGER DI BOLZANO una tragedia italiana in 7809 storie individuali
Ed. MIMESIS. Milano